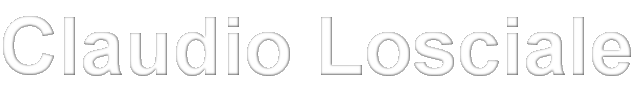Diritto d'autore
Note giuridiche sulla fotografia
A cura dell'Avvocato Salvatore Morvillo esperto nei problemi connessi alla fotografia.
1) Con la formula "diritto d'autore" si vuole significare il diritto che, per legge, spetta a chi crea un'opera dell'ingegno per il solo fatto della creazione (cfr. L. 22/4/41 n° 633 c. d. Legge diritto autore o L. d. A.).
Mentre altri diritti (ad esempio: la proprietà) normalmente si acquistano per contratto o per successione ereditaria o per altre vie, il diritto di autore, cioè il diritto che all'autore spetta sulla sua opera, nasce senz'altro in capo a lui per effetto della sua attività creativa.
Per provare tale diritto è sufficiente dunque che l'autore dimostri di essere il creatore di una determinata opera dell'ingegno. All'autore, in quanto tale, competono poi, come a ogni titolare di diritti (ad esempio: al titolare del diritto di proprietà) determinate facoltà: egli ha così, in via esclusiva, il potere di pubblicare o di lasciare inedita la sua opera: di utilizzarla economicamente, direttamente o cedendo ad altri, in tutto o in parte i "diritti di utilizzazione" che a lui spettano.
Oltre a tali diritti all'autore compete anche quello che si suole definire "diritto morale" cioè il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a ogni deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera che possa essere di pregiudizio alla sua reputazione o al suo onore.
Il diritto morale continua a spettare all'autore anche quando egli abbia ceduto a terzi i diritti di utilizzazione dell'opera.
2) La legge italiana, a seguito delle modificazione introdotte con il d. p. r. 8/1/79 n° 19, ammette alla protezione generale del diritto di autore anche le "opere fotografiche" cioè le fotografie dotate di carattere creativo, così parificate alle opere letterarie, musicali, pittoriche, etc. Diverso regime è invece dettato per le "semplici fotografie" cioè per le fotografie prive di carattere creativo, le quali sono oggetto di una tutela minore. La legge come si vede distingue tra "opere fotografiche" e "semplici fotografie" (prive di creatività) con ciò ponendo ai Giudici problemi di non facile soluzione.
3) Il fotografo ha, per legge, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della sua opera (art.88): ciò significa che all'autore della fotografia, per il solo fatto di averla realizzata, spetta il diritto esclusivo di pubblicarla e utilizzarla economicamente.
Nel caso di "opere fotografiche", cioè dotate di carattere creativo, deve peraltro valere il principio fondamentale in materia secondo cui godimento ed esercizio del diritto d'autore non sono subordinati ad alcuna formalità' e quindi neppure a quella della menzione sugli esemplari della fotografia del nome del fotografo, dell'anno di riproduzione della fotografia etc.
4) L'autore di opera fotografica gode nel nostro ordinamento della protezione del diritto morale di autore (diritto di rivendica della paternità e di opposizione alle modifiche lesive). Questo principio è stato per la prima volta affermato dal Tribunale di Milano (sent. 14112/ 72 in Causa Toscani/Total) il quale ha fatto applicazione dell'art. 6 bis della Convenzione di Bema, del9 settembre 1886 nel testo riveduto a Bruxelles il 26 giugno 1984 reso operante in Italia con legge n. 247 del 1953. Dopo la legge 1911979 il principio trova peraltro la sua piena e definitiva affermazione nella stessa legge. Anche l'autore di opere fotografiche può dunque rivendicare la paternità dell'opera, pretendere di vedere menzionato il proprio nome nelle riproduzioni e opporsi a quelle modifiche dell'opera stessa che possono risultare di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
5) Se la fotografia è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di lavoro, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio compete al datore di lavoro (art. 88 II Comma); al fotografo resta dunque solo il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a modificazioni dell'opera stessa, pregiudizievoli al suo onore o reputazione. L'ipotesi in esame è quella del fotografo che lavora non in via autonoma ma come lavoratore subordinato, alle dipendenze di un datore di lavoro da cui percepisce una retribuzione.
6) Se invece la fotografia è stata ottenuta da un fotografo, libero professionista, in adempimento del contratto stipulato con un cliente, la disciplina legislativa è diversa.
Se nel contratto tra fotografo e cliente è espressamente previsto che il cliente potrà utilizzare la fotografia solo in modo limitato (ad esempio: solo per un certo tempo o solo per un certo impiego) il cliente dovrà astenersi da utilizzazioni non previste e, per poter allargare l'utilizzazione, dovrà accordarsi con il fotografo che potrà subordinare il suo consenso al pagamento di un compenso ulteriore.
Se nel contratto tra fotografo e cliente, invece, nulla è previsto, quante volte si tratti di fotografie di cose in possesso del cliente, quest'ultimo potrà fare l'uso più ampio dell'opera fotografica, senza che il fotografo possa insorgere o reclamare compensi aggiuntivi.
Il sistema qui descritto rende molto importante che il fotografo, allorché gli viene commissionato un servizio, pattuisca espressamente quali usi della sua opera egli intende consentire, avuto riferimento a durata, modalità, canali di sfruttamento etc.
Se il fotografo trascurerà di porre queste limitazioni, il cliente sarà libero di trarre ogni utilità dalle foto e per tutto il tempo che gli piacerà. Le limitazioni pattuite dovranno essere riprodotte anche nelle fatture ma è bene che risultino già, prima della fatturazione, dal contratto. Va ricordato che I se è vero che una fattura contenente l'espressa limitazione di uso delle foto (ad esempio: per uso redazionale) inviata al cliente e da questo ricevuta, trattenuta, pagata senza obiezioni può fondare la presunzione che la limitazione era stata effettivamente pattuita, tuttavia è buona norma fare risultare ogni limitazione dal contratto che precede. la realizzazione dell'opera fotografica e la relativa fatturazione.
7) La legge (art. 91) consente la riproduzione di fotografie nelle antologie scolastiche od in opere scientifiche o didattiche contro pagamento di un equo compenso che è determinato con decreto del Presidente del Consiglio.
Edubbio se questa disposizione debba valere solo per le "semplici fotografie" o anche per le "opere fotografiche". Attualmente è in vigore il D.P.C. 6/7/76 il quale consta del seguente articolo unico.
Articolo unico:
Le tariffe per determinare l'equo compenso dovuto al fotografo per le riproduzioni di fotografie in antologie ad uso scolastico sono fissate come segue: per le fotografie in bianco e nero di opere d'arte figurativa: € 0,40 per ogni fotografia riprodotta; per le fotografie a colori di opere dell'arte figurativa: € 1.50 per ogni fotografia riprodotta; per le fotografie di soggetto diverso da quelli indicati nei paragrafi precedenti: € 0,80 per fotografia, fino ad un massimo di 6 fotografie della stessa opera; per le fotografie pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico interesse: € 0,80 per fotografia, fino ad un massimo di 6 fotografie per ciascun servizio.
I suddetti compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari a decorrere da quello di pubblicazione, che dovrà essere indicato nell'antologia.
La riproduzione nelle antologie dovrà essere accompagnata dalla menzione delle indicazioni prescritte dalla legge (nome del fotografo, data dell'anno di riproduzione della fotografia e nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata se risultano dalla fotografia riprodotta).
L'editore dell'antologia darà notizia della riproduzione al fotografo o suo avente causa.
L'editore dell'antologia notificherà all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica che l'importo del compenso è a disposizione del fotografo o suo avente causa.
Tale notificazione avverrà contestualmente al deposito previsto dall'art. 105 della legge 22 aprile 1941 n. 633.
8) L'art. 89 L. d. A. stabilisce che la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti spettanti al fotografo.
E dubbio se questa norma possa oggi valere anche per l'opera fotografica. In ogni caso non costituisce cessione la consegna del negativo effettuata nell'esecuzione di un contratto di opera, per consentire al committente di riprodurre l'immagine (es. diapositiva).
9) I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica (avente cioè carattere creativo) durano cinquant'anni dall'anno di produzione dell'opera (art. 32 bis L. d. 77) mentre il diritto esclusivo sulle semplici fotografie (non aventi cioè carattere creativo) dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
10) Alcune norme della legge n. 633 del 1941 si occupano del ritratto.
L'art. 98 prevede che - salvo patto contrario - la persona fotografata può riprodurre o far riprodurre il ritratto, senza il consenso del fotografo cui è stato commissionato, salvo pagamento di un equo compenso nel caso di utilizzazione commerciale.
Per contro, l'art. 96, in linea generale, dispone che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio da altri senza il consenso dell'interessato. Il principio però non è senza eccezione; l'art. 97 infatti consente la pubblicazione del ritratto senza consenso dell'interessato - a patto che la pubblicazione stessa non sia offensiva per la reputazione o il decoro della persona ritratta - quante volte la riproduzione dell'immagine sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico. Come si vede la legge qui prevede che il diritto all'immagine deve essere sacrificato all'esigenza di pubblica informazione.
11) La giurisprudenza in tema di fotografia è molto scarsa, salvo per quanto riguarda la riproduzione del ritratto, sul quale tema le decisioni sono molto numerose.
É stata cosi ritenuta lecita, anche in difetto di consenso, la riproduzione del ritratto di una nota cantante (Nilla Pizzi) per la realizzazione di cartoline (Cass. 14/12/63 n. 3150); non lecita invece la riproduzione del ritratto di persona nota per pubblicizzare un prodotto (e.g. divulgazione del ritratto di un personaggio politico per reclamizzare un digestivo; riproduzione delle fattezze di una nota attrice per pubblicizzare un costume da bagno) e per assecondare la curiosità morbosa del pubblico (caso Esfandiari-Rusconi deciso dalla Corte di Milano 19/1/ 71 nel senso della tutela della intimità) o per reali are stampa licenziosa (caso Taio-Balsamo deciso dal Pretore di Roma nel senso che le foto di un'attrice, scattate nel corso di una ripresa cinematografica, non possono essere pubblicate in una sequenza immaginaria di tipo erotico).
Quando all'esistenza del consenso della persona ritratta alla ripresa fotografica e alla pubblicazione delle foto è stato ritenuto (Cass. 29/11/ 73 n. 3290) che tale consenso si può presumere in relazione al carattere della riunione (avvenimento di cronaca), alla qualità dei partecipanti (attori, operatori cinematografici, fotografi) nonché all'atteggiamento compiaciuto del soggetto al momento dello scatto della foto.
12) Il d.p. 8/1/79 n. 19 ha rivoluzionato la disciplina previgente, che faceva della fotografia una Cenerentola del diritto d'autore.
Introducendo però la distinzione tra "semplici fotografie" e "opere fotografiche" ha lasciato ai Giudici un compito molto arduo poiché essi dovranno di volta in volta stabilire se l'autore si è servito della macchina solo per la sua funzione di riproduzione della realtà o se invece ha saputo dare con la macchina una rappresentazione contrassegnata dall'intervento di una propria personalità.
Avv. Salvatore Morvillo